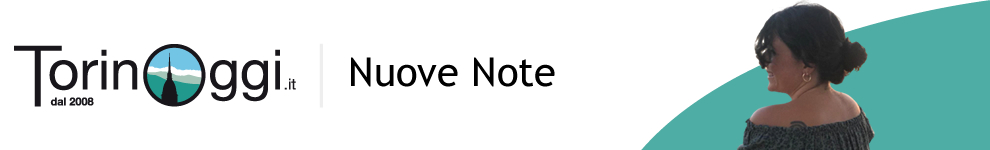La questione delle donne di conforto — termine con cui si indicano le donne impiegate nei bordelli militari giapponesi durante la Seconda guerra mondiale — continua a dividere storici, attivisti e governi. Ma per comprendere davvero il significato e le implicazioni di questo fenomeno, è essenziale collocarlo nel più ampio contesto della prostituzione in tempi di guerra, una realtà antica quanto i conflitti stessi. Tra bordelli ufficiali, regolamentazioni statali e una morale pubblica spesso ambigua, la figura della donna impiegata nei servizi sessuali ai soldati va analizzata non solo come simbolo di oppressione, ma anche come parte di una complessa macchina militare.
Bordelli e guerra: un fenomeno antico quanto i conflitti
La prostituzione militare non è un'invenzione del Giappone imperiale. Già durante il XIX e il XX secolo, potenze europee e coloniali organizzavano strutture per garantire “igiene” e disciplina ai loro soldati. In Francia, le cosiddette maisons tolérées (bordelli legali sotto supervisione statale) erano attivi anche nei territori coloniali, servendo soldati francesi in Africa e Asia. La motivazione era apparentemente pragmatica: ridurre la diffusione di malattie veneree e limitare le violenze sessuali. Analogamente, l’esercito statunitense tollerò la prostituzione in zone di guerra, come testimoniano i casi delle “camptown women” in Corea del Sud dopo il conflitto del 1950.
In questo contesto, i bordelli militari giapponesi non appaiono come un’eccezione. Piuttosto, rappresentano una versione particolarmente organizzata e burocratizzata di un fenomeno diffuso, sebbene moralmente problematico.
Chi erano davvero le donne di conforto?
Secondo le ricerche presentate nel libro The Comfort Women Hoax del giurista J. Mark Ramseyer, le cosiddette “donne di conforto” non furono semplicemente forzate con la violenza o l’inganno, come spesso descritto nella narrativa popolare. In realtà, molte di loro firmarono contratti — talvolta mediati da trafficanti locali, talvolta direttamente con gli operatori dei bordelli — e ricevettero stipendi considerevoli per l’epoca.
Documenti d’archivio giapponesi indicano che le donne di conforto ricevevano pagamenti anticipati tra 500 e 1.000 yen, mentre lo stipendio medio di un sergente dell’esercito giapponese era di circa 30 yen al mese. Tenendo conto dell’inflazione e del potere d’acquisto, questi importi corrisponderebbero oggi a somme pari a decine di migliaia di euro.
Politica, memoria e accuse: il caso sudcoreano
Nonostante la complessità storica, in Corea del Sud la narrativa sulle donne di conforto è diventata un campo di battaglia politico. Il Korean Council for Justice and Remembrance, precedentemente noto come Korean Council for Women Drafted for Military Sexual Slavery, ha per decenni promosso una visione rigidamente vittimista, in cui ogni donna coinvolta era ridotta a schiava sessuale. Questa posizione ha ricevuto ampia simpatia internazionale, portando persino all’erezione di statue commemorative in vari paesi occidentali.
Ma le contraddizioni sono emerse negli ultimi anni. Il caso più eclatante riguarda Yoon Mee-hyang, ex presidente del Consiglio coreano e poi deputata, accusata da un'ex donna di conforto, Lee Yong-soo, di appropriazione indebita dei fondi destinati alle sopravvissute. A queste accuse si sono aggiunti scandali legati alla gestione opaca di case di riposo, donazioni e fondazioni affiliate. In questo contesto, è emerso anche il nome di Kim Sam-seok, sospettato di essere una spia per la Corea del Nord coinvolta nel coordinamento di alcune attività del movimento, secondo quanto riportato da fonti sudcoreane.
Dissidenti accademici: Lew Seok Choon, Song Dae Yup e Park Yu-ha
Contro la narrazione ufficiale si sono schierati anche alcuni intellettuali sudcoreani. Il sociologo Lew Seok Choon ha affermato che molte donne di conforto erano “imprenditrici del sesso” e che definirle tutte vittime è una distorsione storica. Similmente, Song Dae Yup ha criticato l’ideologia anti-giapponese che pervade il dibattito pubblico sudcoreano, proponendo una revisione basata su documenti d’archivio piuttosto che su testimonianze filtrate da decenni di attivismo.
Particolarmente significativa è la figura di Park Yu-ha, autrice del libro Comfort Women of the Empire e docente universitaria. Dopo aver visitato una casa di riposo per ex donne di conforto, Park ha raccolto testimonianze divergenti dalla narrativa ufficiale. Alcune donne dichiaravano di aver ricevuto compensi regolari e di aver mantenuto relazioni non coercitive con i soldati. Per queste affermazioni, Park è stata accusata di diffamazione ed è stata condannata nei tribunali sudcoreani, sebbene abbia ricevuto il sostegno di accademici giapponesi, statunitensi e anche di alcune ex donne di conforto stesse.
Un libro fondamentale: Comfort Women and Sex in the Battle Zone
A sostegno di queste revisioni storiografiche vi è anche il lavoro dello storico giapponese Ikuhiko Hata, Comfort Women and Sex in the Battle Zone. Basandosi su fonti militari, rapporti sanitari e contratti d’epoca, Hata descrive il sistema dei bordelli giapponesi come un’istituzione regolamentata, in cui la coercizione esisteva, ma non era la norma. Il libro ha il merito di restituire complessità storica a un fenomeno spesso banalizzato dalla propaganda.
Diffamazione, censure e verità parziali
Il tema delle donne di conforto è divenuto terreno minato anche per la libertà accademica. Intellettuali sudcoreani e giapponesi che hanno tentato di proporre letture alternative sono stati regolarmente accusati di “giustificazionismo” o, peggio, di collaborazionismo con il nemico. Queste accuse hanno prodotto un clima intimidatorio, che scoraggia ogni tentativo di discussione serena e documentata.
Le implicazioni sono gravi: quando la storia viene utilizzata come arma politica, il rischio è quello di ridurre fenomeni complessi a slogan ideologici. Ma la verità — per quanto scomoda, imperfetta e frammentaria — merita sempre di essere cercata.
Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.