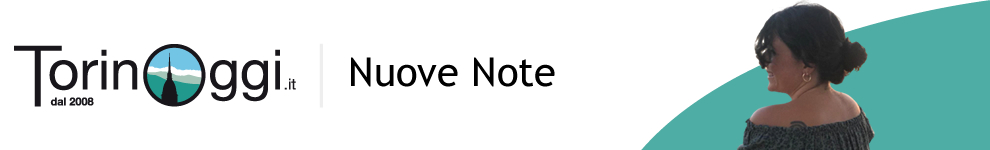Le Alpi che si aprono sulla pianura padana, le valli che scendono dolcemente verso il Mar Ligure, le strade che valicano i colli per poi perdersi in Francia: questo angolo d’Europa è da secoli un crocevia di culture, genti e poteri.
È una terra che porta impresse, sulle rocce come sulle persone, le tracce di un passato turbolento, dove ogni confine era instabile, ogni valico un passaggio da conquistare, ogni porta un’opportunità per entrare in contatto con l’altro.
Le “frontiere mutevoli” non si misurano quindi solamente sulle mappe, ma sulle vite delle persone che in questi luoghi si muovono, combattono, si mescolano, costruendo una identità multiforme che sfida ogni categorizzazione.
È una situazione che ha forgiato quella che potremmo chiamare una cerniera tra l’Italia e la Francia — una terra che ha saputo mantenere viva sé stessa senza perdere l’altro.
Le spade e i bastioni: terre di invasioni e difese
Dall'antichità alle guerre dinastiche: il sangue sulla frontiera
Nella Roma imperiale, le strade che attraversavano le Alpi, come la Via delle Gallie o quella che collegava Augusta Taurinorum (Torino) ad Aosta, aprirono nuove vie per l’esercito, per i mercanti e per le genti.
Le invasioni barbariche, Longobardi, Franchi, forzarono le porte delle Alpi, utilizzando valichi come il Gran San Bernardo per entrare nella pianura padana.
Aosta divenne una porta d’accesso, una roccaforte da presidiare, a partire dalla quale le armate potevano muovere a loro piacimento.
Durante il Medioevo, con l’emergere delle signorie feudali, ogni passaggio divenne un luogo conteso. I Savoia consolidarono il loro potere sulle valli per controllare dazi, pedaggi e strade, aumentando l’influenza sulle regioni che dal Moncenisio portavano a Torino, dalla Valle d’Aosta a Ginevra, dalla Val di Susa a Cuneo.
Le città marinare come Genova combatterono per mantenere le loro vie d’accesso dal mare all’interno delle Alpi, sfidando i poteri feudali per ottenere il dominio sulle strade commerciali.
Nelle guerre di successione che insanguinarono l’Europa dal XVII al XVIII secolo, quella Spagnola, quella Austriaca, le Alpi divennero il palcoscenico di battaglie che ridefinirono i confini.
Le campagne napoleoniche, dal 1796 in poi, segnarono in modo indelebile questo territorio: battaglie come quella di Mondovì o quella di Loano aprirono le porte a una riorganizzazione delle sfere d’influenza.
Le idee rivoluzionarie che varcavano le Alpi portarono a una riformulazione delle entità politiche, come le repubbliche sorelle, che per un breve momento posero fine all’Antico Regime.
Il XX secolo, infine, ha riacceso il fuoco delle armi sulle Alpi. Nella Prima Guerra Mondiale, sebbene il fronte sulle Alpi Marittime sia rimasto secondario, nella Seconda le truppe italiane varcarono il confine per entrare in Francia nel 1940, per poi combattere sulle stesse creste che per secoli furono una barriera.
Dopo l’8 settembre 1943, le resistenze partigiane — tanto quelle italiane quanto quelle francesi — combatterono per liberare questi territori dal nazifascismo, costruendo una memoria comune che va oltre ogni divisione.
Architetture di guerra: fortezze, valli blindate e difese costiere
Le Alpi portano con sé i resti delle loro battaglie.
Il Forte di Bard, in Valle d’Aosta, che controllava l’accesso dal Gran San Bernardo, è divenuto un simbolo delle sfide che si combatterono per ogni valico.
Le fortezze come quella di Exilles in Val di Susa, i bastioni di Cuneo o la Cittadella di Alessandria, che dominava le pianure, raccontano una strategia militare che ha saputo integrare l’architettura con la geografia per aumentare le capacità difensive.
Sulla costa, le torri d’avvistamento, come quelle di Ventimiglia, Nizza o La Spezia, servirono per combattere la pirateria, per segnalare l’avvicinarsi di navi nemiche e per controllare il traffico marittimo.
È un patrimonio che conserva viva la memoria delle sfide che questi territori dovettero affrontare per mantenere la loro identità.
Oltre i confini politici: scambi culturali e tappeti linguistici
Un mosaico di lingue e dialetti: l'eredità viva delle frontiere
È proprio in questi territori che si è formato un mosaico linguistico che riflette secoli di contatti, scambi e mescolanze.
Il francoprovenzale (o patois) parlato in Valle d’Aosta, ad esempio, porta con sé le sfumature delle parlate d’Oltralpe; le varianti occitane delle valli piemontesi (Valli Valdesi, Cuneese) testimoniano una cultura che va oltre ogni confine politico.
Il dialetto ligure, dal genovese all’intemelio, conserva una stretta affinità con le parlate provenzali, a conferma che le Alpi non separano, ma uniscono.
Tradizioni, cucina e influenze reciproche: il patrimonio condiviso
Le cucine di confine mescolano sapori, ingredienti e metodi di cottura che provengono tanto dalla Francia quanto dal Piemonte e dalla Liguria.
Formaggi alpini, polenta, castagne, erbe aromatiche che crescono sulle colline, pesce dal mare, dolci dal sapore intenso: ogni piatto porta in sé una memoria di scambi secolari.
Anche le feste, le processioni, le fiere, come quelle di Cuneo o di Nizza, manifestano quella sincronia che ha permesso a questi popoli di costruire un ponte che va oltre ogni barriera.
Negli stili architettonici, dal romanico delle chiese valdostane all’arabesco delle ville sulla Costa Azzurra, si riflette quella fusione che ha arricchito ogni cultura.
È lo stesso per le correnti artistiche e letterarie: autori, poeti e pittori che, muovendosi da un versante all’altro delle Alpi, si arricchirono di nuove esperienze, contribuendo a quella che potremmo chiamare una civiltà transfrontaliera.
Movimenti di popoli: emigrazione, immigrazione e nuove frontiere
La grande emigrazione: quando il confine era una speranza (XIX-XX secolo)
Nella seconda metà del XIX secolo, le campagne delle valli piemontesi e liguri si svuotavano per la povertà, per la mancanza di terra, per le difficili condizioni di vita.
Moltissimi emigravano oltreconfine, principalmente in Francia, a Nizza, Lione, Marsiglia, dove l’agricoltura, l’edilizia e l’industria richiedevano braccia.
Queste comunità italo-francesi mantennero viva l’eredità delle loro origini, portando con sé dialetti, usanze, sapori che si fusero con le culture d’accoglienza.
È da questo crogiolo che nascono le identità multietniche che vivono sulle due sponde delle Alpi.
L'immigrazione: nuovi incontri e sfide contemporanee (XX-XXI secolo)
Negli anni del boom economico, dal 1950 al 1970, il Nord-Ovest d’Italia divenne una delle principali mete per l’immigrazione dal Mezzogiorno.
Operai, contadini, artigiani si trasferirono dal Sud per contribuire allo sviluppo industriale delle principali regioni del triangolo Torino-Milano-Genova.
Negli ultimi decenni, le sfide poste dai flussi migratori internazionali, dal Maghreb, dal Medio Oriente, dai paesi dell’Est, si sono sommate a quelle degli arrivi dal Sud, modificando il tessuto sociale delle valli, delle campagne e delle principali aree metropolitane.
Ventimiglia, il valico del Tenda, il traforo del Frejus: questi luoghi, che per secoli furono crocevia per mercanti, militari e contadini, sono divenuti corridoi per coloro che fuggono da situazioni di pericolo o di povertà, in cerca di un futuro migliore.
È in questi contesti che si confrontano le sfide principali per l’integrazione, per l’accoglienza, per la solidarietà, in un’epoca che vede riemergere paure, pregiudizi, incomprensioni.
Il passato che modella il presente
Le frontiere che per secoli hanno diviso, protetto o messo in contatto questi territori continuano a influenzare le loro identità.
È dal passato che nasce quella che potremmo chiamare una memoria condivisa, che comprende battaglie, emigrazioni, scambi, mescolanze linguistiche, gastronomiche, artistiche.
È quella memoria che può aiutarci a costruire un futuro dove ogni confine sia un luogo d’incontro, dove le sfide comuni si affrontano insieme, senza perdere di vista le radici che danno a ogni cultura la sua ricchezza.
È proprio sulle Alpi, sulle loro valli, sulle loro strade che si gioca una delle sfide principali per l’Europa del domani: quella di integrare senza perdere l’unicità, quella di costruire una civiltà che sia tanto plurale quanto solidale.
Il nostro gruppo editoriale è presente in tutte le principali città che, da Torino a Nizza, da Cuneo a Ventimiglia, da Aosta a Genova, vivono ogni giorno questi cambiamenti, raccontandoli con cura, passione e professionalità per mantenere viva la memoria del passato e costruire un futuro condiviso.