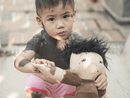In un momento storico in cui l'immagine del muro si sta affermando come il simbolo di un'umanità divisa e conflittuale, parlare di malattia mentale a Collegno significa rompere le barriere per far dilagare la conoscenza, il ragionamento. Un convegno sulla legge Basaglia dentro la Lavanderia a vapore assume così una duplice valenza: da un lato permette di rendere il dovuto omaggio a un luogo che ospitò il lavoro dei pazienti ricoverati in manicomio, dall'altro rappresenta il definitivo superamento di quel momento storico in favore di una rinascita culturale.
La giornata di lavori organizzata dal Ciso Piemonte si poneva l'obiettivo di riannodare le fila di quel lungo percorso che ha portato nel 1978 alla legge 180, la cosiddetta riforma Basaglia. Un cammino non semplice, ricco di ostacoli, che ha dovuto passo dopo passo scardinare il concetto di alienismo per puntare all'inglobamento del diverso, di quell' “altro” pericoloso e sconosciuto da tenere confinato al di fuori della società. Uno spaccato di storia che ha visto coinvolto non solo il settore sanitario, ma anche che le diverse compotenti sociali e politiche su cui si è poggiata quella che è stata una svolta epocale, una vera rivoluzione.
Le manifestazioni in ricordo della legge Basaglia si concluderanno il 13 maggio 2018. “Si è voluto iniziare a onorare la ricorrenza un anno prima proprio per permettere un recupero storico di ciò che è stato l'avvicinamento alla riforma”, ha spiegato Franco Lupano, presidente del Ciso, che da decenni porta avanti un approfondito lavoro di ricerca sulla storia sanitaria in Piemonte, andando ad analizzare le dinamiche interne al rapporto tra medici, malati e istituzioni. “Dentro il Ciso operano sia medici che storici, ed è una compresenza molto importante, perché la storia della medicina va fatta da entrambe le figure per avere una visione globale dei fenomeni. Ricordare è sempre fondamentale, e il modo più efficace per farlo è lasciare la parola a chi ha vissuto nell'epoca dei manicomi, facendo riemergere ciò che succedeva al loro interno, cosa voleva dire vivere in manicomio, tanto per i malati quanto per chi ci lavorava”.
Gli storici Luciano Sorrentino e Giacomo Vaccarino hanno ripercorso le diverse tappe dell'ambito normativo psichiatrico dal 1904 al 1978 e il configurarsu della riforma psichiatrica nella provincia di Torino. Rispetto al resto dell'Italia, il nostro territorio si è distinto, a partire dagli anni Sessanta, per un'attenzione peculiare al disagio psichico, con l'obiettivo di riorganizzare le competenze in ambito psichiatrico per attribuirle a struttura articolate sul territorio, superando il tradizionale manicomio. “Una situazione difficile da gestire, con intervneti terapeutici improbabili o difficoltosi, giustificata soltanto dall'esigenza di rivovero istituzionalizzato per individui ritenuti pericolosi per la società”. Già nel 1969, anno caldo per l'intera società, gli psichiatri torinesi chiedevano l'inserimento dell'assistenza psichiatrica all'interno della medicina generale, con un decentramento territoriale delle struttura a essa dedicate. “Il tutto all'interno di un ambizioso cambio di prospettiva culturale e politica, che vede in primo luogo l'individuo – sano o malato che sia – con le sue istenza fondamentali di una vita sana, dignitosa e soddisfacente, e non più le esigenze difensive della società”.
Ezio Cristina, psichiatra, ha poi presentato gli atti del consiglio di amministrazione dal 1968 al 1978, dieci anni caratterizzati da un impegno per il superamento dell'istituzione manicomio, dall'attenzione alle assunzioni e ai licenziamenti del personale, e per quelle che venivano definite “evasioni”, vale a dire l'allontanamento dei pazienti dall'istituto: “è la dimostrazione dell'inutilità, oltre che della antiterapeuticità di misure restrittive forzate, ma, soprattutto, sfata il luogo comune secondo cui una volta ricoverati in manicomio non era più possibile uscirne”.
Tanti gli interventi che si sono susseguiti nel corso della giornata. Dal ricordo di Villa Azzurra, il manicomio dei bambini a Grugliasco, nella parole dell'ex bibliotecario Giorgio Tribbioli, al racconto della nascita dell'Associazione per la lotta alle malattie mentali, fondata a Torino nel '67 per liberare i pazienti dalle condizioni degradanti in cui erano tenuti nei manicomi. Un lavoro proseguito anche oltre la legge Basaglia, con l'obiettivo di garantire la dignità a tutti coloro che patiscono un disagio psichico e ai loro familiari. Si è poi parlato del ruolo delle cooperative nella fase di progettazione e riconversione dopo la riforma, così come del peso del servizio sociale negli anni precedenti la legge. Un focus è stato fatto anche sull'operato dei media nel trattare la malattia mentale, quando i temi psichiatrici iniziano ad affermarsi sui giornali come inchieste-denuncia delle condizioni disumane in cui vivevano i pazienti.
Infine, la riflessione conclusiva, summa di tutto l'excursus compiuto, è stata proposta da Enrico Zanalda, direttore del dipartimento di salute mentale della Asl TO3. Cos'è rimasto dell'ospedale psichiatrico dal 1978 al 2018? Aver adottato il modello proprio della psichiatria di comunità quale riferimento dell'assistenza psichiatrica italiana non è ancora sufficiente: “sono necessari adeguati investimenti perché il sistema della rete dei dipartimenti di salute mentale possa rispondere alla crescente domanda di trattamenti. Serve un giusto incremento di risorse per sanare il gap tra quanto si potrebbe realizzare e quanto effettivamente si riesce a fare”. Una questione aperta, che lascia intravedere oltre il muro un panorama ancora in divenire.